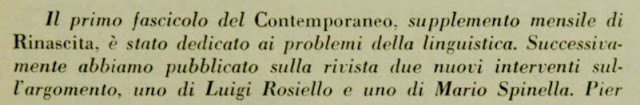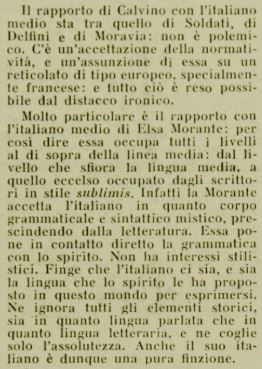"Le pagine corsare "
dedicate a Pier Paolo Pasolini
Eretico e Corsaro

DIARIO LINGUISTICO
Pier Paolo Pasolini
Rinascita, ANNO XXII/numero 10 - marzo 1965, pagg. 24-26
Biblioteca Gino Bianco
La questione linguistica pone il PCI di fronte alla necessità di verificare la reale potenzialità e i reali obiettivi della sua lotta per l’egemonia. Questo è il discorso vero che il PCI deve affrontare: e per affrontarlo realmente, deve concedere – senza timore di offendere il proprio onore o di ammettere insieme qualche propria insufficienza nel passato o nel presente – che c’è la possibilità, o il pericolo, che «la nuova stratificazione tecnologica» appartenga in effetti alla classe egemonica (in potenza) della nuova borghesia. Il fatto che ognuno di noi, ossia l’intera nazione, possa essere «utente» di quel linguaggio tecnologico – inteso, insisto, come nuova spiritualità o cultura – non esclude che il reale possesso di quel linguaggio sia di coloro che attraverso esso esprimono la loro reale esistenza.
Per noi – e genericamente inteso, quasi in modo antropomorfico, per il PCI – il linguaggio tecnologico è uno dei tanti elementi espressivi, qualsiasi sia la sua tendenza, mentre per la borghesia tecnocratica-neocapitalistica è un tutto. In senso quasi metafisico o universalistico, il linguaggio tecnologico può essere inteso come il linguaggio dell’eternità industriale (secondo una definizione di Moravia). Infatti, ipoteticamente, sarebbe del tutto concepibile un mondo, interamente occupato al centro dal ciclo produzione-consumo, che avesse come lingua la sola lingua tecnologica: tutte le altre lingue potrebbero essere tranquillamente concepite come «superflue» (o come sopravvivenze folcloristiche in lenta estinzione). Perché, in un mondo come schematicamente possiamo immaginarlo, al limite dello sviluppo tecnocratico, ci dovrebbero essere delle altre lingue, o dei momenti linguistici diversi, oltre a quella della produzione e del consumo? Sì, ripeto, sono concepibili: ma come «lingue del tempo libero», come «hobbies familiari». Già, ma sempre al limite, noi concepiamo quel tempo libero come occupato dall’uomo che noi conosciamo; e presupponiamo la presenza di una famiglia che noi abbiamo sperimentato. Mentre, nella visione ultima e apocalittica dell’eternità industriale
come riproduzione del determinismo della natura, l’uomo sarà un’altra cosa: e la sua «comunicazione» linguistica sarà in funzione non più tradizionalmente umana…

Capire e distinguere perché tale fenomeno avvenga, in che termini avvenga ecc. ecc. è uno degli atti fondamentali del «rinnovamento del marxismo». Se tale rinnovamento, soprattutto per il PCI – che è considerato ed è all’avanguardia in tale operazione – è dovuto all’apparizione di nuovi strati di realtà, allo sviluppo imprevisto di certe situazioni sociali, al di là del limite delle previsioni di Marx e di Lenin. Questo ormai lo sanno tutti. E il rinnovamento, però, non deve avvenire attraverso una riscoperta di Marx, un ritorno alle fonti (come tendono a fare i «puri» del PSIUP o di certi movimenti disinteressati, per esempio il gruppo di «Quaderni Piacentini»): in tal caso un rinnovamento del marxismo si presenterebbe come uno dei tanti ritorni al Vangelo nella storia della Chiesa: e si sa che tutti tali ritorni sono «rientrati», a gloria della Chiesa. Bisogna certo rileggere Marx e Lenin, ma non come si rilegge il Vangelo. Il «nuovo spirito tecnologico» è un fatto senza precedenti e senza equivalenti nel passato: e non era prevedibile, perché non erano prevedibili le concrete realizzazioni scientifiche, e quindi la qualità della loro quantità sempre più immensa.


Ancora una cosa, prima di passare agli esami particolari dei vari interventi: Citati sul «Giorno» osservava che, con tutti i denti fuori, un «compagno di viaggio» (dai lunghi periodi latineggianti-burocratici sconvolti da un nuovo spirito contraddittorio: la ricerca della rapidità e della precisione comunicativa) tendeva a sostituire il vecchio, caro, insostituibile «sì» («il Bel Paese dove il sì suona»), con un orrendo «esatto». Questo «esatto» non è direttamente tecnologico: ma è prodotto del «principio» tecnologico della chiarezza, dell’esattezza comunicativa, della scientificità meccanica, dell’efficienza, che diventa mostruoso nella sua iniziale fase di contatto con il substrato tradizionale umanistico e espressivo. L’influenza tecnologica è indiretta: è il suo principio in qualche modo trascendente quello che conta. La televisione è uno dei modi di concrezione e di irradiazione di tale principio. La parola «esatto» era l’urlo di trionfo ufficiale con cui Mike Bongiorno accoglieva la soluzione buona del quiz. È evidentemente questa la strada del prestigio della parola «esatto»; il modello linguistico profondo è nel nuovo spirito tecnologico dell’Italia del Nord industrializzata fino al possibile inizio dell’era tecnocratica, ma il modello immediato passa attraverso una mediazione infrastrutturale che lo deforma e lo deformerà, lungo una infinità di fasi linguistiche.

.png)