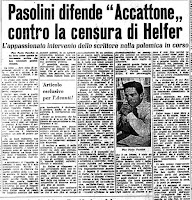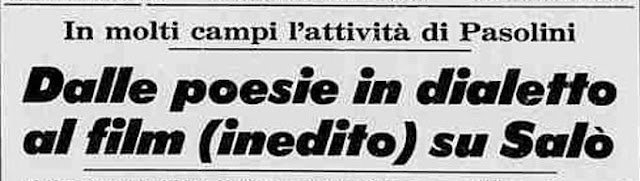Benvenuto/a nel mio blog
Benvenuto nel blog
Questo blog non ha alcuna finalità di "lucro".
Viene aggiornato di frequente e arricchito sempre di nuovi contenuti, anche se non in forma periodica.
Sono certo che navigando al suo interno potrai trovare ciò che cerchi.
Al momento sono presenti oltre 1600 post e molti altri ne verranno aggiunti.
Ti ringrazio per aver visitato il mio blog e di condividere con me la voglia di conoscere uno dei più grandi intellettuali del trascorso secolo.
Pasolini - VITA, OPERE E MORTE
Visualizzazione post con etichetta censura. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta censura. Mostra tutti i post
martedì 8 giugno 2021
Pasolini "Terza B facciamo l'appello - Trascrizione - Prima parte, introduzione di Enzo Biagi
lunedì 14 dicembre 2020
Pasolini difende "Accattone" contro la censura di Helfer - L'Avanti, venerdi 20 ottrobre 1961
"Le pagine corsare "
dedicate a Pier Paolo Pasolini
Eretico e Corsaro
Pasolini difende "Accattone"
contro la censura di Helfer
L'Avanti, venerdi 20 ottrobre 1961
( @ Trascrizione dal cartaceo curata da Bruno Esposito )
 |
| L'Avanti, venerdi 20 ottrobre 1961 |
La lotta - dico la lotta di argomenti e di allusioni - che si è accesa, a distanza, tra me e Helfer, è assolutamente impari.
Io credo tutta l'anima a quello che faccio e che dico - che faccio e dico proprio nell'atto del fare e del dire - e perciò sono vulnerabile, scoperto, esasperato.
Helfer non crede a quello che fa e che dice, perchè quello che fa e che dice non consiste, realmente, nell'atto concreto e immediato del fare e del dire e perciò è invulnerabile, riparato, freddo.
Io sono uno scrittore e lui è un uomo di governo: a me non interessa di perdere o di guadagnare nulla, perchè il mio interesse è quello della poesia, non è cioè, un interesse pratico. A lui invece il perdere o il guadagnare interessa fino in fondo, perchè il suo interesse è totalmente pratico, un atto di potere politico.
Io se fossi insincero, non sarei uno scrittore. Helfer, se fosse sincero, non sarebbe un censore nello stato attuale dell'organo censorio. I nostri argomenti sono di natura totalmente diversa: un luogo franco, dove, realmente scontrarsi, non lo potremo mai trovare.
<< Accattone >> è l'oggetto in comune, è vero: ma lo è solo nominalmente. Perchè io, quando cerco di chiarire l'aspetto politico della mia opera poetica, lo faccio ingenuamente, scoprendo tutte le carte, perchè, ripeto, non potrei mai essere insincero. L'insincerità sarebbe per me un'intima, ed essa si inappellabile, condanna. Quando invece Helfer cerca di chiarire l'aspetto estetico dei miei assunti politici, lo fa aprioristicamente, tenendo ben coperte le sue carte. La sincerità è incompatibile con la sua posizione politica.
E' possibile, dunque, una discussione? No, certo, perchè io l'ho perduta in partenza. Chi si getta allo sbaraglio, con passione, con dolore, senza curarsi della propria incolumità, è destinato a perdere. Anche se la sua sconfitta, è, intimamente una vittoria.
Helfer sa benissimo che ho ragione io. E io so che lo sa. Questo da esasperazione a me, sicurezza a lui.
Cionondimeno, non posso esimermi dal lottare. Un rassegnato silenzio, da parte mia, sarebbe una colpa. Helfer mi ha messo davanti agli occhi un mulino a vento, e io non posso che buttarmici addosso alla disperata.
Il mulino a vento è nella fattispecie, il comunicato che Elfer ha dato alla stampa, a proposito di <<Accattone>>, della sua quarantena in censura e della protesta di un gruppo di scrittori, magistrati, uomini politici, cattolici, liberali e marxisti.
Se Helfer si rileggesse il comunicato nella sua intimità spoglia della sua carica, dei suoi doveri, dei suoi credo - in presenza cioè - per un attimo, un solo attimo, della sua anima - si accorgerebbe di doverne arrossire fino ai capelli.
Egli, intanto (per cattivarsi le simpatie dei fascisti?) dice che il mio film si svolge esclusivamente in un ambiente di lenoni, ladri, prostitute, violenti. Ebbene? Intanto non è vero: la protagonista, Stella, è, nella sua totale semplicità di alienata, qualcosa come un angelo: un angelo senza volontà, passivo, arreso, ma ma intimamente impastato do incorruttibile bene. Un personaggio un po charlottiano, lo so: l'ho voluto cosi. La vuole dimenticare, Helfer? E il fratello di Accattone? E la povera Nannina, con le sue cinque creature alle sottene?
Questo a voler accettare lo schema, del tutto falso e in malafede, di Helfer: perchè in realtà bisognerebbe dirgli e ridirgli che ci sono dei << peccatori >> nel film, è vero, ma il loro peccato è meccanico, esteriore a loro, imposto da una cosi atroce condizione umana d'alienazione pura, la lasciarli indenni e innocenti nelle loro scatenata vitalità. Che una specie di torbidi moralisti calcolatori della nostra classe dirigente non sono certo più vicini al bene di quelle povere creature, che negano i propri impulsi sinceri perchè li temono come negazione dell'unico modo di vita che è loro consentito...
Dunque, è il momento dei <<psichicamente deboli >>. Questa è la grande svolta della cultura italiana. il mondo di << Accattone >>, potrebbe malamente influire sui minorati psichici, di cui l'Italia sembra improvvisamente popolata. A leggere il comunicato di Helfer ( a volerlo prendere sul serio ), si disegna d'incanto intorno a noi, un'Italia-clinica, un'Italia-Neuro, un'Italia di minorati. Frotte di scemi girano per le strade, resse di nevrotici affollano le sale cinematografiche: un paesaggio che soltanto un umorista sarebbe capace di descrivere. Io, non ho certo voglia di scherzare.
Ma perchè questa Italia di minorati sarebbe cosi diabolicamente influenzata da << Accattone >>? Perchè, osserva Helfer, il mio personaggio, che è un lenone, è visto da me con << simpatia >>, e quindi, riuscendo simpatico, potrebbe indurre tutti i milioni di scemi che secondo Helfer popolano l'Italia, a fare i lenoni. Ah, non c'è dubbio, la prospettiva è molto divertente! Soprattutto implica una estrema fiducia di Helfer negli italiani! I padri di famiglia, che tanta speranza ripongono in uomini, come Helfer - i censori, i difensori dell'ordine - sono serviti: basta, per Helfer, che i loro figli vadano al cinema a vedere il mio film perchè ne escano scemi come sono, lenoni. L'amore che Helfer ha per i suoi cittadini è un vero e proprio insulto alla loro dignità: ma, pazienza, pazienza... Senonchè tanta cura del cristiano Helfer verso i suoi concittadini di certo è cultura inferiore, è viziata da un errore fondamentale di interpretazione.
La << simpatia >> di cui Helfer mi accusa per il mio personaggio - per il mio povero Cataldi Vittorio, detto Accattone - è una cosa che egli ha totalmente dimenticato: la pietà cristiana.
Sono marxista: ma sono anni che dico che non ci può essere marxismo senza quel profondo impulso irrazionale di amore in cui, in tanti secoli, si è distillato lo spirito cristiano.
Helfer legga i miei libri: o se non ne ha voglia, legga la molto più facile e compromettente rubrica che tengo da un anno su un settimanale di sinistra e vedrà se questa è la prima volta che rivendico questa intima pietà cristiana alle origini del socialismo. se dubita, si faccia spiegare dai suoi amici fascisti, Helfer, perchè io sono marxista: per quali altre ragioni, se non per questo ideale amore cristiano per il prossimo. Certo, questo è il primo momento, il momento irrazionale, appunto, di una ideologia: è il primo, ma è quello che permane più a lungo, e più tenacemente, nell'atto poetico.
Io non potevo rappresentare Accattone che con simpatia: E l'ha ben capito Carnelutti, quando parla del profondo dolore che pervade tutto il mio film. Il peccato fa pietà, e la pietà fa piangere.
Non c'è nessuno di coloro che ha visto il film, che non siano usciti dalla sala della proiezione stretti dall'angoscia: un'angoscia fino eccessiva, direi, per quanto mi riguarda, se, alla fine, io penso che la qualità estetica dovrebbe bruciarla o lenirla. Ma non è della qualità del mio film, ch'io parlo.
L'incredibile, lo scandaloso della dichiarazione di Helfer, è alla fine. Egli propone, o si propone, di rimandare il nullaosta al film dopo che sia stata approvata la nuova legge sulla censura la quale prevede elevato a diciott'anni il limite della minore età cinematografica.
In altre parole Helfer non vuole responsabilità. Anzitutto credo che sia legalmente ridicolo che un sottosegretario in funzione si appelli a una legge non in funzione, e che forse non sarà mai in funzione. Ma non è l'aspetto giuridico della faccenda che mi compete. Volevo solo qui dedurre la viltà dell'atto: la mossa abile e cinica. Io confesso che credevo Helfer un uomo in buona fede, un << trentino moralista e fanatico >>, ma in buona fede. L'ho anche detto, in giro, agli inizi di questa triste storia: e molte persone possono testimoniarlo. E invece no: anche lui è uno dei tanti qualunquisti morali, che, come si dice, tirano a campare, vivono di compromessi e ripieghi. Il moralismo è idiota, è disumano, è insano: ma almeno è rispettabile, come tutte le malattie, e spesso implica un certo coraggio, una certa purezza. Ma quello di Helfer, allora, non è nemmeno moralismo: è un patteggiare con amici e nemici, è una condotta di compromesso, una rinuncia alla propria responsabilità, che non gli fa onore.
Io, per conto mio sono molto scoraggiato. Vedo un futuro nero per << Accattone >>. Dalla malafede, dall'odio aprioristico, dal qualunquismo, dal conformismo, non si può sperare nulla.
Pier Paolo Pasolini
Perché non piace ai censori il "potere" visto da Pasolini - Dacia Maraini
"Le pagine corsare "
dedicate a Pier Paolo Pasolini
Eretico e Corsaro
Perché non piace ai censori il "potere" visto da Pasolini
Dacia Marami giudica "Salò"...
l'ultimo film del regista scomparso recentemente
La Stampa
Anno 109 - Numero 264
Sabato 15 novembre 1975
(Trascrizione curata da Bruno Esposito)
Il nuovo film di Pier Paolo Pasolini «Sade-Salò» è stato bocciato dalla censura perché gli italiani non sarebbero abbastanza maturi per questo genere di pellicola.
Dovremmo ringraziare i censori che ci proteggono con tanta solerzia da spettacoli evidentemente pericolosi per la nostra integrità spirituale. Per fortuna che ci sono loro a proibirci i film di autori problematici per meglio farci apprezzare quelle geniali commedie all'italiana tanto educative e salutari per tutti noi! E' una vera fortuna, altrimenti come farebbe il popolo italiano, notoriamente ritardato e infantile, a distinguere il vero dal falso?
Ma l'Italia, ormai dovremmo saperlo, è divisa in due: da una parte ci sono cinquanta milioni di bambini e dall'altra alcuni padri molto premurosi che si preoccupano della salute morale di questi bambini, prodigandosi nella scelta di ciò che può loro giovare, fuori da ogni inquietudine e rischio intellettuale.
D'altronde ci siamo abituati, nessuno ci fa più caso: da quando nasciamo, entriamo sotto la tutela di qualche padre; sia nella scuola, durante le lezioni o gli esami, sia quando finiamo davanti a qualche commissione, oppure quando ci troviamo per malaugurato caso di fronte ai giudici di un tribunale o nel letto di un ospedale, o peggio, in prigione, oppure semplicemente di fronte alla scelta di un film da vedere.
Abbiamo anche la gioia di riconoscerli immediatamente questi padri, perché sono sempre gli stessi: adoperano lo stesso linguaggio per esprimere lo stesso cinico e pedestre buonsenso. Tutti questi padri poi fanno capo a quei pochi solerti padri pubblici che da trent'anni amorosamente vegliano sulla «grande famiglia italiana».
Si dà il caso che io, pur essendo due volte minore, una perché cittadina italiana e una perché donna, abbia visto il film di Pasolini. E vorrei qui esprimere il mio parere, contrario e opposto a quello dei padri della censura. Il pubblico, quando i censori decideranno che sarà diventato maturo (due anni? cinque? dieci?) deciderà chi di noi ha ragione.
Il film di Pasolini è una gelida e triste meditazione sulla sessualità e il potere. Una sessualità pervertita che nasce da un potere pervertito: il fascismo.
La bellezza del film sta in un rigido e regolare andamento da composizione musicale medievale; ci sono le cantate a tema, i duetti, i cori, le semplici e severe sonate con l'uso di pochi strumenti, tutte giocate su due o tre note dolenti, fisse. Ogni episodio si apre e si chiude con un movimento circolare, sapiente ed enigmatico.
Il film non ha niente di sensuale: l'autore non si immedesima mai, nemmeno per un momento col sentimento sadico degli aguzzini. Egli porta per mano lo spettatore lungo i gironi dell'inferno fascista, avvicinandolo al dolore quieto e terribile delle vittime, suggerendogli pietà e non piacere.
I quattro aguzzini infatti, sebbene siano presentati come uomini colti (ma non troppo), raffinati, signorili e perfino cortesi, sono assolutamente e definitivamente allontanati dalla simpatia del pubblico per mezzo dell'osservazione allibita e disgustata delle loro facce brutali e stupide (della stupidità che viene dall'egocentrismo e dall'avidità di piaceri).
I ragazzi e le ragazze invece sono mostrati nelle loro carni livide e intirizzite, sempre e soltanto come vittime, costrette alla passività dai fucili e dai coltelli che i giovani avanguardisti manovrano con disinvoltura.
Così nel film tutto è chiaro fin dall'inizio: i carnefici sono coloro che hanno in mano il potere e lo usano per soddisfare con la forza i loro appetiti sadomasochistici; le vittime sono i deboli, i poveri, gli sfruttati.
Da questo punto di vista Pasolini non ha fatto che riprendere i contenuti di De Sade. Nel libro («Le centoventi giornale di Sodoma»,) le vittime non sono mai consenzienti. Solo che mentre in De Sade questa mancanza di partecipazione delle vittime alla gioia sessuale ha uno scopo soprattutto stimolante per i carnefici, cioè rappresenta un meccanismo puramente funzionale, in Pasolini ha un significato sociale, politico.
Il sadismo e la violenza, anche quelle imposte coi guanti bianchi, accompagnate da soavi parole e dolci note, attorno a tavole imbandite, sono decisamente presentate come il momento più idiota e corrotto del potere fascista; il momento della sua agonia panica e morbosa.
Fin dalle prime bellissime inquadrature della pianura padana intiepidita da un debole sole autunnale, Pasolini chiarisce subito da che parte sta: con i deboli, i perseguitati, contro la violenza e i soprusi.
Significativo della concezione complessiva del film è che la sola notazione positiva riguarda un giovane comunista che si ribella alle leggi del potere e muore fucilato nel momento dell'amore (ancora una volta significativo che l'amore sia, all'interno della villa fascista, assolutamente vietalo e bandito) nudo, serio, gentile, col pugno chiuso teso verso i suoi aguzzini, accanto alla sua innamorata africana.
Il fascismo, ci dice Pasolini con le sue immagini terse e violente, riduce le persone a oggetto. Il male sta prima di tutto li.
E che lo si faccia in nome della purezza della razza, o di un grande impero o del superomismo o del nazionalismo, non importa. La sua ideologia aberrante non può che portare gli uomini all'odio e all'assassinio.
In questo senso si potrebbe dire che egli volontariamente contraddice gli ultimi discorsi fatti pubblicamente sui guasti del consumismo e sull'omologazione dei valori che avrebbero resi fra loro simili per cultura e abitudini i giovani delle destre ai giovani delle sinistre. Ma è anche vero che questo livellamento, per Pasolini, era cominciato col boom degli Anni 60.
Nel film comunque non c'è nessuna possibile somiglianza fra dominanti e dominati, fra ricchi e poveri, fra potenti e sfruttati. Un solco profondissimo separa i gusti, i desideri, le abitudini degli uni da quelli degli altri, senza contaminazione possibile. Potremmo addirittura dire che il film è manicheo in maniera didascalica: male e bene coesistono senza comunicare.
Ci sono alcuni ragazzi corrotti, ma sono pochissimi e abbiamo ben visto come sono stati strappati al lavoro dei campi e costretti con la forza a partecipare al lugubre festino dei signori. Perfino le quattro narratrici, in questa limpida gerarchia del potere, occupano un posto di sottordine, alla mercé delle voglie brutali dei padroni. E non è un caso che una di queste guardiane, quella che accompagna le sevizie degli aguzzini con le patetiche note del pianoforte, si uccide buttandosi dalla finestra. Tutti gli altri sono testimoni impotenti di un dolore e di una offesa senza fondo.
Proprio per fare capire fino a che punto gli abusi sessuali servono a dividere il potere dal non-potere, gli orrori sadici sono rinchiusi da Pasolini all'interno di cornici doppie e triple, rapprese nei momenti di maggiore crudezza, dentro i tondini di un binocolo, al di là di una finestra, in un mondo lontano e silenzioso, da incubo. Il triste sguardo del regista vaga sulle persone e le cose raggelate dal male con allibita consapevolezza e inquieta pietà.
Il finale dei due ragazzi che ballano fra di loro infine sembra porre un ansioso interrogativo sul futuro: vinceranno gli aguzzini con la loro cultura inumana e violenta o vincerà il nuovo umanesimo e quindi la dolcezza e quindi l'amore che anche negli occhi stupidi e rozzi dei ragazzi corrotti a momenti si fa viva quasi loro malgrado?
Dacia Maraini
giovedì 6 ottobre 2016
Salò e le centoventi giornate di Pasolini - La censura
"ERETICO & CORSARO"
Salò di Pasolini
La censura
La censura
A un giornalista che, durante l’ultima conferenza-stampa rilasciata a Cinecittà prima della fine delle riprese (il 9 maggio 1975), gli chiedeva se prevedesse difficoltà di censura, Pasolini aveva risposto, sorridendo:
“Suppongo che ci saranno, speriamo di vincerle. Oggettivamente ci saranno sicuramente delle lotte da fare”.
Così fu.
31 ottobre 1975
Il produttore Grimaldi presenta Salò alla Commissione di censura il 31 ottobre 1975, con una lunghezza dichiarata di 3297 metri e accertata dalla Commissione di 3192 (i 105 metri di differenza corrispondevano semplicemente ai titoli di testa e alla pellicola di coda del film). Pasolini viene assassinato il giorno dopo, nella notte fra il 1° e il 2 novembre, ma dopo dieci giorni dal delitto la censura non si era ancora pronunciata,
11 novembre 1975
La prima sezione della Commissione di revisione esamina il film, dopo avere ricevuto una comunicazione del produttore che “dichiara di essere disposto ad eseguire anche dei tagli se la Commissione lo ritiene opportuno”. La deliberazione è la seguente: “il film nella sua tragicità porta sullo schermo immagini così aberranti e ripugnanti di perversioni sessuali che offendono sicuramente il buon costume e come tali sopraffanno la tematica ispiratrice del film sull’anarchia di ogni potere. Si esprime pertanto parere contrario alla proiezione in pubblico del film stesso”.
Si solleva un’ondata di indignazione e protesta cui parteciparono numerose personalità della cultura italiana. La PEA fa ricorso il 29 novembre.
22 novembre 1975
Il film viene presentato per la prima volta in pubblico al Festival di Parigi in una sala sugli Champs-Élysées, dove venne organizzata una conferenza stampa contro la censura cui intervengono, fra gli altri, Bernardo Bertolucci, Laura Betti, Liliana Cavani, Luigi Comencini, Gillo Pontecorvo, Francesco Rosi e Sonia Savange. Il 9 dicembre il Salone Pier Lombardo e il Club Turati organizzarono a Milano una serata a inviti con un dibattito sulla censura che vide la partecipazione, fra gli altri, di Piero Ottone e Giovanni Testori e si concluse con la proiezione del film.
18 dicembre 1975
Si riunisce la Commissione di appello di revisione cinematografica. Dopo due ore di discussioni, il film viene assolto, con queste motivazioni:
La maggioranza ritiene [...] di non poter condividere il parere della Commissione di primo grado, che il film costituisca offesa al buon costume. Lo spettacolo suscita sempre e soltanto disgusto. Il sesso – chiamato a simboleggiare il possesso dispotico, devastatore e distruttore della creatura umana, quale viene attuato dal potere politico assoluto, che il regista accusa di giungere all’annientamento della personalità morale e fisica dell’individuo, degradandolo ad oggetto – non assume mai nel film il carattere di una intenzionale ed eccitante allusione alla lussuria. La Commissione di appello, pertanto, a maggioranza, in riforma del diverso avviso della Commissione di primo grado, esprime parere favorevole al rilascio del nullaosta di proiezione in pubblico del film, con il divieto di visione per i minori degli anni 18.
Salò può quindi essere proiettato in Italia senza subire nessun taglio. L’autorizzazione del ministero reca la data del 23 dicembre 1975 con il nullaosta n. 67445.
10 gennaio 1976
Prime proiezioni italiane, esclusivamente a Milano, in tre sale, il Majestic, il Nuovo Arti e il Ritz. Nei primi due giorni il film attirò 15.675 spettatori, nostante l’irruzione di alcuni anonimi che, confusi fra gli spettatori, lanciarono fialette di liquido puzzolente in sala. L'indomani il film viene denunciato dall’Associazione Nazionale degli Alpini che si ritiene oltraggiata da una sequenza in cui il Duca, imitato dagli altri carnefici, intonava il canto alpino della brigata “Julia” Sul ponte di Perati.
13 gennaio 1976
Il film venne sequestrato per ordine del sostituto procuratore della Repubblica Roccantonio D’Amelio che accoglie le denunce di associazioni e privati cittadini. Apre un procedimento penale contro il produttore Grimaldi per commercio di pubblicazioni oscene. Dopo la Commissione di censura, è quindi la magistratura a intervenire e stavolta il film rimarrà sotto sequestro per oltre un anno.
30 gennaio 1976
Si tiene la terza udienza del processo contro il produttore, condannato a due mesi di reclusione, a duecentomila lire di multa e al pagamento delle spese processuali per “avere realizzato e messo in circolazione a scopo di lucro” uno spettacolo “costituito tutto da scene e da linguaggio a carattere osceno”.
19 febbraio 1976
La Procura generale di Roma apre un procedimento penale contro il produttore per corruzione di minorenni e atti osceni in luogo pubblico, in quanto si ritiene che alcuni degli interpreti del film fossero di età inferiore ai diciotto anni al tempo delle riprese. Ma la PEA dimostra che gli attori erano tutti maggiorenni e il procedimento venne quindi archiviato il 23 settembre 1976.
17 febbraio 1977
La Corte d’Appello di Milano accoglie il ricorso di Grimaldi e ordina il dissequestro del film. La sentenza del pubblico ministero conclude “per l’assoluzione dell’imputato con la formula ampia riconoscendo al film il valore di opera d’arte, sempre che venissero enucleate le scene da ciascuno indicate, la cui ripetizione appariva superflua per il messaggio trasmesso agli spettatori del regista Pasolini. Proponevano perciò, l’uno in via principale e l’altro in via subordinata il taglio di quelle sequenze”. In altre parole, Salò poteva essere considerato un’opera d’arte dopo il taglio di sei sequenze (a tanto corrispondevano esattamente “le scene da ciascuno indicate”) ma nella sua integralità, quindi con le sei sequenze, non poteva essere considerato opera d’arte, bensì spettacolo osceno. Infatti la corte ha ravvisato nelle sequenze incriminate
la rappresentazione di fatti osceni che non essendo necessari per la tematica trattata non potevano ritenersi riscattati dai pregi artistici del film, ma ne alteravano l’armonia. Ne ha proposto, perciò, l’eliminazione col taglio delle sequenze nella pellicola, prima che essa venga restituita all’avente diritto e nonostante ha concluso per l’assoluzione di quest’ultimo, ritenendo per quelle scene esclusa la sua punibilità per errore sul fatto, errore giustificato e scusabile volta che il film aveva ottenuto l’approvazione della Commissione di censura.
5 marzo 1977
La Corte d’Appello di Milano ordina la restituzione della pellicola alla PEA “previa eliminazione e confisca” delle seguenti sequenze:
- Nella seconda parte del film la scena riguardante la sodomizzazione del presidente Durcet e quella della masturbazione del ragazzo inesperto e del fantoccio;
- nella terza parte del film dopo il matrimonio dei due ragazzi la scena della sodomizzazione del personaggio di Blangis;
- nella quarta parte del film la scena della masturbazione del Presidente davanti lo specchio e nella quinta quella della sodomizzazione del Vescovo
10 marzo 1977
Sia pure così tagliato, a distanza di quattordici mesi dalla prima distribuzione italiana, il 10 marzo del 1977 Salò esce finalmente nelle sale italiane, rigorosamente vietato ai minori di anni diciotto. In quei quattordici mesi si era creata una forte (e anche morbosa) curiosità intorno al film, tanto che al termine dello sfruttamento nelle sale vennero staccati circa due milioni di biglietti. Non mancarono episodi di teppismo neofascista: a Roma, il giorno stesso della prima proiezione, in un cinema sulla via Salaria una trentina di giovani entrano in sala facendo esplodere bombolette di gas maleodorante, altri lanciarono vernice nera contro le vetrine d’ingresso infrangendo i cristalli a sassate. Quattro giovani vennero fermati dai carabinieri e si dichiararono militanti di estrema destra. Fra loro venne identificato Valerio Fioravanti, che in seguito sarebbe stato condannato come uno degli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna. Nella stessa serata tre telefonate anonime seminarono allarme in altrettanti cinema annunciando la presenza di ordigni esplosivi in sala
7 giugno 1977
Nella cittadina di Grottaglie, a venti chilometri da Taranto, uno spettatore del film – poi dichiaratosi orgogliosamente militante locale del MSI nonché sodale del principe Junio Valerio Borghese, comandante e fondatore della Xa MAS – presenta un esposto contro il film. Il pretore di Grottaglie Evangelista Boccuni si reca di persona a vedere il film e, noncurante della sentenza assolutoria della Corte d’Appello di Milano, dispone il sequestro di Salò in tutto il territorio nazionale, con queste motivazioni:
Mi sono convinto della particolare oscenità del film e della mancanza in esso di qualsiasi pregio artistico. In particolare alcune scene, tra cui quelle dell’ingestione di escrementi umani e di sodomizzazione, sono improntate alla più ripugnante lascivia e costituiscono la esaltazione esasperata di forme aberranti di deviazione sessuale. Non so se l’artisticità dell’opera sia venuta meno in seguito ai tagli imposti dalla Corte d’Appello di Milano, ma ritengo che, sia pure attraverso la strumentalizzazione di un determinato periodo storico, il film attualmente sia osceno.
Contro il sequestro del film intervenne, fra gli altri, “L’Unità” che ricorda come la Corte costituzionale avesse deciso per la “libertà provvisoria dei film, nelle more del giudizio conclusivo” (Altro sequestro per il Salò di Pasolini!, 7 giugno 1977), mentre il giornale ufficiale del Vaticano, l’“Osservatore romano”, plaude al sequestro (in un articolo anonimo dell’8 giugno 1977): “A conforto dell’amarezza e del disorientamento di quei cittadini che si sentono confusi (per non dire di più e di peggio) da sentenze che danno patenti d’arte a film nei quali la presenza dell’osceno e dell’abietto è patente e irrefutabile”. Il 9 giugno la PEA denuncia il pretore di Grottaglie per abuso d’ufficio e violazione delle norme procedurali e il 18 giugno il sostituto procuratore Nicola Cerrato dissequestra il film dichiarando illegittimo l’intervento di Boccuni, contro cui, il 13 ottobre del 1978, si apre un procedimento penale per il reato di abuso di atti d’ufficio. Il 18 giugno 1977, la Procura della Repubblica di Milano ordinò il dissequestro di Salò su tutto il territorio nazionale.
15 febbraio 1978
La Corte di Cassazione di Milano annullò la sentenza relativa alle sei sequenze tagliate che a quel punto possono essere reintegrate nel film.
All'estero
In Francia la Commissione preliminare di censura propose il divieto ai minori di anni diciotto ma la Commissione plenaria, il 13 maggio 1976, votò a maggioranza (quattordici voti contro nove) l’interdizione totale del film. Intervenne il ministro della cultura Michel Guy che il 19 maggio autorizzò la proiezione pubblica del film con il divieto ai minori di anni diciotto. Ma in effetti Salò, distribuito dal coproduttore Les Artistes Associés, uscì inizialmente in un’unica sala parigina, cui se ne aggiunsero in seguito altre quattro, dato il successo di pubblico. La programmazione a Parigi durò ininterrottamente per molti anni e, in modo più saltuario, viene ancora proiettato in una sala della capitale francese.
In Germania, dove era uscito alla fine di gennaio del 1976, il film fu sequestrato il 6 febbraio ma soltanto a Stoccarda, per ordine del procuratore locale, mentre nell’intero territorio della Repubblica Federale, così come in quello della Repubblica Democratica, Salò fu programmato regolarmente riscuotendo un notevole successo di pubblico e lo stesso avvenne in altri paesi, fra cui il Giappone dove fu distribuito tempestivamente nel 1976 (come in Svezia e in Danimarca), mentre rimane tuttora proibito in Russia e in Cina.
Nel Regno Unito, il British Board of Film Censors (BBFC) rifiutò di autorizzarne la diffusione il 25 gennaio 1976. Fu proiettato per la prima volta al cineclub Old Compton Street a Soho, un anno più tardi, nel 1977, in edizione integrale e senza certificazione del BBFC. Dopo due giorni intervenne la polizia che bloccò le proiezioni e sequestrò il film che successivamente venne tagliato in un’edizione supervisionata dal segretario del BBFC, James Ferman. Soltanto nel 2000 l’edizione integrale di Salò è stata finalmente autorizzata per le proiezioni in pubblico nel Regno Unito.
Negli Stati Uniti Salò non ha mai avuto una distribuzione regolare ma è stato mostrato soltanto in occasione di festival o rassegne. Nel 1994 il film fu al centro di un ‘caso’ giudiziario quando un poliziotto di Cincinnati arrestò i proprietari di una libreria gay che noleggiavano abusivamente la videocassetta. L’episodio suscitò la reazione di alcune personalità della cultura e dello spettacolo, fra cui Martin Scorsese, che firmarono una petizione a favore del film. La corte assolse i proprietari e incriminò il poliziotto ma non si pronunciò sull’oscenità o meno del film. Salò ha conosciuto un’adeguata diffusione soprattutto a New York e grazie all’accurata edizione Dvd realizzata da Criterion nel 2008.
L’Australian Classification Board vietò il film nel 1976 e tale rimase fino al 1993 quando l’edizione integrale fu autorizzata con un R-18 (vietato ai minori di anni diciotto). Ma nel febbraio 1998 fu nuovamente vietato e soltanto nel 2010 è stata autorizzata la proiezione, nonostante le forti proteste, fra gli altri, della Family Voice Australia e dell’Australian Christian Lobby. In Nuova Zelanda, il film è stato vietato nel 1976 e ancora nel 1993. Dopo la concessione, nel 1997, di un permesso speciale per una proiezione integrale in un festival, nel 2001 è stata autorizzata l’edizione Dvd in versione integrale, ovviamente con il divieto ai minori di diciotto anni.
CINETECA DI BOLOGNA
Via Riva di Reno, 72
40122 BOLOGNA
Iscriviti a:
Post (Atom)