"Le pagine corsare "
dedicate a Pier Paolo Pasolini
Eretico e Corsaro
Nuove questioni linguistiche
Prima parte
Rinascita, sabato 26 dicembre 1964
Biblioteca Gino Bianco
(Trascrizione curata da Bruno Esposito)
Il rapporto di Calvino con l’italiano medio sta tra quello di Soldati, di Delfini e di Moravia: non è polemico. C’è un’accettazione della normatività, e un’assunzione di essa su un reticolato di tipo europeo, specialmente francese: e tutto ciò è reso possibile dal distacco ironico.
Molto particolare è il rapporto con l’italiano medio di Elsa Morante: per così dire essa occupa tutti i livelli al di sopra della linea media: dal livello che sfiora la lingua media, a quello eccelso occupato dagli scrittori in stile sublimis. Infatti la Morante accetta l’italiano in quanto corpo grammaticale e sintattico mistico, prescindendo dalla letteratura. Essa pone in contatto diretto la grammatica con lo spirito. Non ha interessi stilistici. Finge che l’italiano ci sia, e sia la lingua che lo spirito le ha proposto in questo mondo per esprimersi. Ne ignora tutti gli elementi storici, sia in quanto lingua parlata che in quanto lingua letteraria, e ne coglie solo l’assolutezza. Anche il suo italiano è dunque una pura finzione.
Quasi tutti gli autori che ho nominato – e anche quelli che non ho nominato, ma che si collocano sopra la linea dell’italiano medio – hanno coi loro eroi e col loro ambiente, un rapporto naturale di parità: culturale, sentimentale e linguistica. Insomma, i loro eroi sono borghesi, come loro, e i loro ambienti sono borghesi, come i loro. Sicché essi possono entrare, quasi insensibilmente, nell’animo dei loro personaggi, e «vivono» i loro pensieri: creano cioè la condizione stilistica di un discorso libero indiretto. Usano quindi la loro lingua: ed è uno scambio di lingue che avviene a un livello di parità, come dicevo. In modo che la lingua del loro personaggio diventa una lingua scritta e tutto sommato letteraria, mentre la lingua dello scrittore – che si immedesima nel suo personaggio – si fa non più che vivace o espressiva.
Nel caso poi che l’eroe sia un eroe popolare, la sua lingua, vissuta dallo scrittore, non è che la lingua dello scrittore abbassata di un solo grado, non una mimesis vera e propria, ma una specie di lunga «citazione» attenuata. È il caso, per esempio, della Ciociara di Moravia, dei leggeri piemontesismi dei personaggi di Soldati, delle accentuazioni emiliane del parlato borghese di Bassani ecc. ecc.
Esiste tuttavia un rilevante fenomeno che cambia radicalmente i termini di questa prospettiva. Si dà il caso cioè che qualche volta l’autore borghese «riviva» completamente il discorso parlato del suo personaggio, e questo personaggio appartenga alla classe operaia o contadina: comunque sublinguistica e dialettale. Qual è il rapporto di Gadda con l’italiano medio? Egli, naturalmente, come ogni scrittore di valore, lo trova assolutamente infrequentabile, e ne è quindi centrifugato. Ma allora, nel caso di Gadda, dovremo aggiungere sulla lavagna del nostro schizzo geometrico, una nuova linea: una linea a serpentina che, partendo dall’alto, scenda, intersecando la linea media, verso il basso, e poi torni di nuovo, sempre intersecando la linea media, verso l’alto, e poi di nuovo verso il basso ecc.
Insomma il discorso libero indiretto in una pagina scritta implica un’incursione verso le lingue basse, la koinè fortemente dialettizzata e i dialetti: a fare carico di materiali sublinguistici. Ma tali materiali – e questo è il punto – non vengono portati al livello della lingua media, per essere quivi elaborati e oggettivizzati quali contributo all’italiano medio: no, essi, attraverso la linea a serpentina, vengono portati nella zona alta, o altissima, ed elaborati in funzione espressiva o espressionistica.
Ma esiste anche un altro tipo di linea a serpentina, non in sola funzione espressionistica, ma oggettiva o realistica. Prima però di descrivere lo schema di questa operazione linguistica, occorre fare un preambolo. Il lettore ha già capito bene che tutto questo mio schizzo di storia letteraria come storia dei rapporti dello scrittore con la lingua media, si accampa per intiero entro i limiti degli anni cinquanta. Per completare tale schizzo occorrerà che io aggiunga un altro elemento tipico della letteratura di quegli anni. Essi sono stati caratterizzati da una ricerca ideologica con ambizioni fortemente razionalistiche (si è ambito insomma fare una revisione di tutta la letteratura antecedente, dall’ermetismo dell’anteguerra al neorealismo del dopoguerra). Contemporaneamente e in parte contraddittoriamente a tale revisione razionalistica, ha avuto luogo una sorta di sperimentalismo che conteneva in sé quegli elementi espressionistici del decadentismo e quegli elementi sentimentali del neorealismo che si volevano ideologicamente superare.
Lo sperimentalismo letterario aveva come base l’esperienza del discorso libero indiretto gaddiano, la «linea a serpentina» intersecante dall’alto al basso l’italiano medio (sempre più traumatico come espressione del mondo borghese). Tuttavia in tale operazione c’era un’infinitamente maggiore ambizione di oggettività che in Gadda: rimaneva, nel fondo, espressionistica, perché il materiale recuperato rivivendo il monologo interiore di un eroe dialettale, veniva elaborato per contaminazione nelle alte sfere della lingua letteraria raffinata, un po’ come in Gadda, appunto.
Ma, rispetto a Gadda, l’operazione era fortemente semplificata: intanto, nella zona alta, mancavano i plurilinguismi tecnologici: e l’altezza letteraria si configurava come una lingua unica. Inoltre, nella zona bassa, i parlanti venivano scelti con una funzione specifica di ricerca sociologica e di denuncia sociale: anche qui, niente pluridialettismi, ma un dialetto unico in una situazione circostanziata. Il discorso libero indiretto era solo un mezzo, prima, di conoscere e poi di far conoscere, un mondo psicologico e sociale sconosciuto alla nazione.
L’allargamento contenutistico era un effetto della poetica del realismo, e quindi dell’impegno sociale, l’allargamento linguistico era un contributo a una possibile lingua nazionale attraverso l’operazione letteraria.
Oggi, quel tipo di impegno appare retorico e inadeguato, e insieme appare illusoria l’ambizione di creare attraverso la letteratura (come del resto si è per tanti secoli creduto) i presupposti di una lingua nazionale.
Si tratta insomma del riconoscimento di una crisi – e di una crisi molto grave – nel senso che: a) il mondo letterario oggetto della revisione polemica degli anni cinquanta, non esiste più, oppure si ripresenta sotto un aspetto – l’avanguardia – che sembra riprodurre vecchie istanze letterarie novecentesche, mentre in realtà si tratta di un fenomeno del tutto nuovo e diverso; b) l’operazione linguistica che ha come base il discorso libero indiretto e la contaminazione, si rivela improvvisamente come superata, per un imprevisto stingimento dei dialetti come problema linguistico e quindi come problema sociale.
Questa crisi linguistica – e non soltanto stilistica – è la spia che sta accadendo nella nostra società qualcosa di profondamente nuovo. Anticipando tutte le altre osservazioni che si potrebbero fare – per esempio, le indicazioni date in questo senso dalle avanguardie – non esiterei a radicalizzare questa crisi attraverso quella che Fortini, citando Majakovskij, chiama la «fine del mandato» dello scrittore, ossia la fine non solo dell’impegno, ma di tutti quei concetti, del resto assolutamente impopolari, che si sono presentati come surrogati o aspetti evoluti dell’impegno. Nella sede socio-moralistica in cui Fortini compie le sue indagini non sono abbastanza chiare le ragioni storiche di tale «fine del mandato»: forse in una sede neutrale e in qualche modo più scientifica qual è la ricerca linguistica, si può osservare meglio, a maggiore distanza, la serie delle causali.
Già alla fine degli anni cinquanta si avevano i primi sintomi di una crisi che allora pareva di restaurazione. Quale informazione rara, poco nota ai non addetti ai lavori, collocherei l’inizio di tale crisi nella «reazione puristica» (reazione a quelle ricerche plurilinguistiche, dialettali, sperimentali, che erano state la forma letteraria concreta dell’impegno) dovuta all’iniziativa di un gruppetto di scrittori napoletani riuniti intorno a una loro rivista.1 Tuttavia protagonisti, in parte involontari, di simile reazione, consideriamo pure Cassola e Bassani, attraverso la loro disperata e poetica nostalgia borghese. Il loro stile (l’ho accennato) non è che una serie continua e sia pur coperta di «citazioni» del linguaggio borghese e piccolo-borghese usato dai padri e dai nonni professionisti e dalle loro cerchie provinciali. In questi due scrittori la ricerca era autentica, e, specialmente Bassani ha dato, attraverso questa mimesis dello stylus médius (invento una categoria sconosciuta sia allo storico che alla stylcritik) delle opere di poesia.
Ma la ripercussione nella società letteraria di una simile operazione – spogliata di necessità e divenuta paradigma – si identificava col neopurismo piccolo-borghese elaborato dai suddetti scrittori napoletani e s’inseriva nell’insieme di quell’operazione reazionaria (revival classicistico e neodecadentistico, riscoperta da parte della critica giornalistica e di qualche parte del pubblico di valori che parevano superati per sempre) che ha preparato la presente situazione di disgregazione e di confusione. È vero: oggi, a una lettura neutrale, succede, per esempio, che nel contesto gaddiano assuma una forte significanza tutto il quantitativo colto e tecnologico, mentre tende a risuonare fioco il quantitativo allocutorio popolare-dialettale; è vero anche che il discorso rivissuto in funzione di denuncia di un mondo miserabile, ladro, affamato, disponibile perché preistorico, sembra d’improvviso un fenomeno stilistico superato – e i Riccetti e i Tommasi si muovono remoti come in un’urna greca; è vero anche che un’operazione simile, portata, più attualisticamente nel cuore di una fabbrica come l’Olivetti, a rivivere i farneticanti discorsi interiori degli Albini Saluggia, sembra altrettanto ingenua e appartenente a un mondo di bontà e di solidarietà superate dalla vertiginosa evoluzione della fabbrica stessa. Tuttavia anche la reazione a tutto questo – la borghesia nobilitata e «ritrovata» come un tempo perduto, di Bassani, Cassola, Soldati o Prisco, e insomma di ogni purista rifacitore eletto di lingua borghese – sembra situarsi al di là di un limite storico, e di non trovare più al di qua di tale limite nessun destinatario in quanto complice di una simile nostalgia.
Insieme a tale devitalizzazione delle più recenti esperienze letterarie, va collocata la vitalità almeno apparente delle avanguardie, che sono poi per un linguista il sintomo più clamoroso della crisi culturale, priva fino a questo momento di spiegazioni non generiche. Le linee sopra e sotto l’italiano medio su cui si è svolta la storia letteraria recente come storia dei rapporti degli scrittori con la loro lingua di classe – sono comunque linee di lingua letteraria, di letteratura. In questi primi anni del sessanta si è visto invece un tipo di rapporto nuovo, almeno teoricamente: un rapporto che non si colloca nell’àmbito della letteratura, ma anzi parte da una base d’operazione dichiaratamente non letteraria. Io credo che le avanguardie non siano quello che si è sempre detto, con banalità inaccettabile, ossia delle ripetizioni delle avanguardie novecentesche. Per le due seguenti ragioni: 1) Le avanguardie classiche ponevano le loro istanze anarchiche e sovvertitrici in rapporto con la situazione a loro presente; avevano della società un’idea stabile e statica, e vi si ponevano come alternativa altrettanto stabile e statica. Le avanguardie del sessanta pongono invece le loro istanze dissacratorie contro una situazione, per così dire, prefutura: sono messianici, demandano al futuro – scimmiottandolo – la situazione dissacrata e rovesciata per definizione (ecco perché si possono anche «integrare» nel presente, e non presentare come dinamitardi). 2) Le avanguardie classiche continuavano a fare la letteratura, e conducevano la loro azione antilinguistica con strumenti letterari: il loro non era che un innovazionismo fine a se stesso e portato alle estreme, e perciò scandalose, conseguenze. Invece le avanguardie di oggi conducono la loro azione antilinguistica da una base non più letteraria, ma linguistica: non usano gli strumenti sovvertitori della letteratura per sconvolgere e demistificare la lingua: ma si pongono in un punto linguistico zero per ridurre a zero la lingua, e quindi i valori.
La loro non è una protesta contro la tradizione ma contro il Significato: i luoghi da distruggere non sono gli stilemi, ma i semantemi.
Tale posizione delle avanguardie si è mostrata finora inattaccabile, e coloro che hanno tentato di attaccarla sono caduti nella banalità, sono sempre risultati misteriosamente sconfitti. Probabilmente perché mentre il luogo zero delle avanguardie corrisponde a un reale momento zero della cultura e della storia, i luoghi da dove la letteratura si difende non hanno più nessuna corrispondenza con una realtà che si sta modificando. Dico subito, tuttavia, che il momento zero scelto dalle avanguardie è solo apparentemente una scelta spavaldamente libera: esso è in effetti una accettazione passiva. Essi suppongono di trovarsi per libera scelta in un luogo dove si trovano invece per coazione.
E dico anche subito che il punto di vista più giusto per osservare e comprendere questa modifica del paesaggio storico reale, è quello che si trova sulla sommità delle proprie esperienze storiche, anche se ormai superate, o rivissute a rovescia come delusione.
Ci troviamo dunque in un momento della cultura imponderabile, in un vuoto culturale, popolato da scrittori ognuno dei quali non fa che seguire una propria storia particolare, come un’isola linguistica o un’area conservatrice. Non si tratta della solita crisi, ma di un fatto del tutto nuovo, che evidentemente si ripercuote dalle strutture della società.
Bisognerà dunque uscire per un momento dalla letteratura, e mettere in stretto contatto fra loro due scienze che con la letteratura confinano: la sociologia e la linguistica.
Diamo dunque uno sguardo sociolinguistico al panorama italiano di questi anni.
Possiamo cominciare, credo nel modo più lecito, dal luogo più vicino: questo, questo che ho sotto il naso, la mia prosa enunciativa. Che, non essendo prodotto di uno specialista, non può non colpire subito per la sua alta percentuale di tecnicismi. Se poi si risale alle origini di tali tecnicismi, la cosa si fa ancora più significativa: essi infatti provengono qui non tanto dalla scienza linguistica, quanto dalla sociologia, per la maggior parte: il resto da altri linguaggi tecnicistici, i più disparati. Sono insomma soccorso, nello spiegare una situazione letteraria, dall’oggetto stesso della mia ricerca extraletteraria. L’osmosi del linguaggio critico, da qualche anno in Italia, non è più col latino, secondo la tradizione anche filologica, ma col linguaggio della scienza. Del resto tutta la terminologia descrittiva della situazione di caos in cui si trova la letteratura – terminologia usata sia dalle avanguardie che dalla sopravvivente diaspora letteraria – è quella dell’industria culturale e della sociologia (oltre quella ormai classica della medicina, della psicanalisi, delle scienze economiche e soprattutto del marxismo).
Si potrebbe notare inoltre come i contributi tecnici dovuti alla stessa linguistica siano di uno speciale carattere: essi tendono a strumentalizzare esplicitamente il linguaggio, attraverso l’idea acuita e dominante della sua strumentalità.
Questa idea della lingua come strumento – proprio nel senso positivo indicato dalla semiotica – è il segno dominante di tutto il panorama linguistico che ci circonda.
Osserviamo subito al di là di questo primo fenomeno che abbiamo sotto il naso, a un settore finitimo. Per esempio il linguaggio del giornalismo. In questi ultimi tempi attraverso una iniziale e quantitativamente irrilevante regolamentazione snobistica di calco sul francese o l’inglese (dovuta alla stampa borghese radicale-illuministica), non c’è dubbio che il linguaggio giornalistico italiano ha assunto dei veri e propri caratteri specialistici. Lo regola e lo fissa un tipo speciale di comunicatività, presupponente una società completamente rappresentata dalla sua opinione pubblica, a un certo livello pseudo-razionalistico. Così che un giornalista può inventare solo dentro un sistema ristrettissimo, e ogni sua invenzione non deve essere però scandalizzante: deve essere collaudata e comunque prefigurata secondo una statistica – ancora dilettantesca e pseudo-scientifica – della richiesta della massa. Ma comunque da questa determinata. Un articolo giornalistico caratterizzato da espressività viene cestinato perché il lettore medio provvederebbe da sé a ignorarlo. Il linguaggio giornalistico è dunque estremamente strumentalizzato, secondo una ipotesi nuova della società come società di un certo elevato tenore razionalistico e quindi antiespressiva. Esso inoltre ritaglia dalla grammatica italiana solo quegli elementi che servono alla comunicazione, e ricava così per eliminazione una grammatica in certo modo rivoluzionaria rispetto i caratteri espressivi della grammatica tradizionale.
Molte volte, appunto, una lingua specialistica può essere caratterizzata dalla pura e semplice selettività: come per esempio la lingua della televisione. Se la televisione occupandosi nelle sue trasmissioni di tutto lo scibile – non avendo dunque competenze particolari – deve poter parlare di tutto: facendo coesistere nei suoi comparti stagni, sotto diversi cartelli segnaletici, varie lingue speciali, tutte però caratterizzate da alcuni fenomeni simili: selezionatori, appunto: l’eufemismo, la reticenza, il cursus pseudo-parlato, la sdrammatizzazione ironica ecc. ecc. Se nella lingua della televisione, in pratica è possibile adoperare tutte le parole, in realtà un’alta percentuale delle parole di una lingua è esclusa: così che il particolarismo della sottolingua televisiva consiste nella sua settaria selettività.
Per quel che ci riguarda, inoltre, il linguaggio televisivo pare aver accantonato la sua funzione didascalica in direzione di un bell’italiano, grammaticalmente puro fino a un fondamentale purismo: ora la funzione didascalica della televisione pare orientarsi verso una normatività di grammatica e di lessico non più purista ma strumentale: la comunicazione prevale su ogni possibile espressività, e quel po’ di sciocca e piccolo-borghese espressività che rimane è in funzione di una strumentalità brutale.
Un’altra osservazione che serve fare, sul linguaggio televisivo, è più marginale ma non meno interessante: la monotonia dei diagrammi delle proposizioni di quel tipico campione televisivo che è il dettato del telegiornale. Esso non parrebbe neanche italiano. Il reticolato della frase ripete moduli il più possibile uguali, evitando ogni espressività diagrammatica, addirittura anche col tono della voce. Pare di sentire un annunciatore francese o cecoslovacco. Tale monotonia comincia già a essere presa come modulo di discorso parlato serio. Le persone di infima cultura credono che l’italiano vada parlato così, attraverso una serie di proposizioni dal diagramma possibilmente unificato anche nella pronuncia.
Del resto tale tipo di discorso è ormai quello che ufficialmente sostituisce il vecchio tipo di discorso enfatico. Osserviamo il linguaggio dei politici: e prendiamo come campione il brano di un recente messaggio inaugurale, a caso:
«La produttività degli investimenti del piano autostradale dipende dunque dal loro coordinamento in una programmazione delle infrastrutture di trasporto, che tenda a risolvere gli squilibri, ad eliminare le strozzature, a ridurre gli sperperi della concorrenza tra i diversi mezzi di trasporto, a dare vita insomma ad un sistema integrato su scala nazionale».
È una frase tratta da un discorso di Moro. Nel significativo momento dell’inaugurazione dell’autostrada del Sole (significativo in quanto tale «infrastruttura» è certo un momento tipico e nuovo dell’unificazione linguistica): ma non si tratta di un discorso a tecnici come il quantitativo di terminologia tecnica, enorme, potrebbe far credere; si tratta di un discorso a un pubblico normale, trasmesso per televisione a un numero di italiani di tutte le condizioni, le culture, i livelli, le regioni. Inoltre, non si tratta di un discorso di circostanza (una vecchia inaugurazione), ma di un discorso che Moro ha investito di un’alta funzionalità sociale e politica: le sue frasi così crudamente tecniche hanno addirittura una funzione di captatio benevolentiae: sostituiscono quei passi che un tempo sarebbero stati di perorazione e enfasi. Infatti Moro strumentalizza l’inaugurazione dell’autostrada per fare un appello politico agli italiani, raccomandando loro un fatto politicamente assai delicato: quello di cooperare al superamento della congiuntura: cooperare idealmente e praticamente, essere, cioè, disposti ad affrontare dei sacrifici personali. Una tale raccomandazione nell’italiano che noi siamo abituati a considerare nazionale, avrebbe richiesto un tour de force dell’ars dictandi: colon simmetrici, cursus latineggianti, lessico umanistico e clausole enfatiche. Qualcosa di fondamentale è dunque successo alle radici del linguaggio politico ufficiale.
Esso, insieme al linguaggio letterario, è sempre stato caratterizzato da quel fenomeno anacronistico in quanto tipicamente rinascimentale che è l’osmosi col latino. Ora tale fenomeno è stato sostituito alla base da un altro fenomeno, è osmosi col linguaggio tecnologico della civiltà altamente industrializzata.
La caratteristica fondamentale di tale sostituzione è che mentre l’osmosi col latino, di tipo eletto, tendeva a differenziare il linguaggio politico dagli altri linguaggi, la tecnologia tende al fenomeno contrario: a omologare, cioè, il linguaggio politico agli altri linguaggi.
Si potrebbe dire, insomma, che centri creatori, elaboratori e unificatori di linguaggio, non sono più le università, ma le aziende.
Si osservi per esempio il potere di suggestione linguistica enorme che hanno gli slogans nel «linguaggio della pubblicità»: linguaggio vero e proprio, in quanto sistema con le sue norme interne e i suoi princìpi regolatori tendenti alla fissazione. Parte di queste sue norme e di questi suoi princìpi linguistici cominciano già a passare alla lingua parlata: ma ciò che è maggiormente rilevante è l’archetipo linguistico offerto dallo slogan: un massimo addirittura metafisico di fissazione diagrammatica.
Anche nel linguaggio della pubblicità, naturalmente, il principio omologatore e direi creatore è la tecnologia e quindi la prevalenza assoluta della comunicazione: sicché lo slogan è l’esempio di un tipo finora sconosciuto di «espressività». Il suo fondo, infatti, è espressivo: ma attraverso la ripetizione la sua espressività perde ogni carattere proprio, si fossilizza, e diventa totalmente comunicativa, comunicativa fino al più brutale finalismo. Tanto che anche il modo di pronunciarla possiede una allusività di tipo nuovo: che si potrebbe definire, con una definizione monstrum: espressività di massa.
Infine: il linguaggio comune, o franco – quella koinè dialettizzata, in basso, latinizzata in alto – ch’è stata finora la santissima dualità italiana, e, in quanto tale, lingua non nazionale. Ora, questa koinè presenta dei segni di profonda modificazione nel senso della tendenza all’unità. Dovrei portare come esempi di questa koinè modificata delle conversazioni registrate. Non sono uno specialista, non ne ho. Mi affido all’esperienza del lettore. Esso converrà con me che gran parte del parlato nel Nord si è fortemente tecnicizzato. Capita ogni momento di sentire tali tecnicizzazioni, tenui al livello delle necessità elementari e quotidiane, forti fino a costituire un vero e proprio linguaggio specialistico-gergale, al livello del mestiere, della professione, dello scambio commerciale, della vita d’azienda. In una pagina fortemente caricaturale ma sostanzialmente registrata di Ottiero Ottieri, leggiamo:
«Ma non l’avevamo mandato su Pavia?».
Farina: «Dottore, c’è rimasto due mesi! Abbiamo provato su Monza». Carlo sbircia il telefono, fulmineo: «Beh, che ha fatto su Monza?». Cavalli: «Calava. L’ho spostato io su Codogno».
Carlo: «Mi dovete ricalcolare l’incidenza dei trasferimenti sul costo di distribuzione. Noi dobbiamo tener ferma una politica aziendale di spinta, ma non possiamo nemmeno superare il 32%!».
«Certo, certo dottore.»
«Al di là del 32% occorre un ridimensionamento.»
Scambi linguistici di questo genere sono ormai la regola dell’Italia industriale ed europeizzata. Essi portano dei caratteri nuovi a quella pseudo-unificazione che avevano dato all’italiano i linguaggi burocratici e commerciali: caratteri nuovi dovuti alla novità spirituale del fenomeno. Né burocrazia né commercio erano fatti spiritualmente nuovi nell’uomo e nell’italiano: la tecnica sì.
Inoltre: caratteri nuovi si sono presentati varie volte nella lunga storia della nostra nazione, ma la lingua vi ha sempre reagito adottando tali novità come nuove stratificazioni linguistiche da aggiungere alle altre: si trattava di una lingua soltanto letteraria e non nazionale, quindi non poteva né fagocitare né superare le vecchie stratificazioni con le nuove, e si limitava ad ammassarle, aumentando continuamente e assurdamente il proprio patrimonio grammaticale e lessicale.
Oggi, è dunque per un fatto storico d’una importanza in qualche modo superiore a quella dell’unità italiana del 1870 e della susseguente unificazione statale-burocratica, che ci troviamo in una diacronia linguistica in atto, assolutamente senza precedenti: la nuova stratificazione linguistica, la lingua tecnico-scientifica, non si allinea secondo la tradizione con tutte le stratificazioni precedenti, ma si presenta come omologatrice delle altre stratificazioni linguistiche e addirittura come modificatrice all’interno dei linguaggi.
Ora, «il principio dell’omologazione» sta evidentemente in una nuova forma sociale della lingua – in una cultura tecnica anziché umanistica – e il «principio della modifica» sta nell’escatologia linguistica, ossia nella tendenza alla strumentalizzazione e alla comunicazione. E questo per esigenze sempre più profonde di quelle linguistiche, ossia politico-economiche.
Si può dire insomma che mai nulla nel passato, dei fatti linguistici fondamentali ebbe un tale potere di omologazione e di modifica su piano nazionale e con tanta contemporaneità; né l’archetipo latino del rinascimento, né la lingua burocratica dell’Ottocento, né la lingua del nazionalismo. Il fenomeno tecnologico investe come una nuova spiritualità, dalle radici, la lingua in tutte le sue estensioni, in tutti i suoi momenti e in tutti i suoi particolarismi.
Qual è dunque la base strutturale, economico-politica, da cui emana questo principio unico, regolamentatore e omologante di tutti i linguaggi nazionali, sotto il segno del tecnicismo e della comunicazione? Non è difficile a questo punto avanzare l’ipotesi che si tratti del momento ideale in cui la borghesia paleoindustriale si fa neocapitalistica almeno in nuce, e il linguaggio padronale è sostituito dal linguaggio tecnocratico.
La completa industrializzazione dell’Italia del Nord, a livello ormai chiaramente europeo, e il tipo di rapporti di tale industrializzazione col Mezzogiorno, ha creato una classe sociale realmente egemonica, e come tale realmente unificatrice della nostra società.
Voglio dire che mentre la grande e piccola borghesia di tipo paleoindustriale e commerciale non è mai riuscita a identificare se stessa con l’intera società italiana, e ha fatto semplicemente dell’italiano letterario la propria lingua di classe imponendolo dall’alto, la nascente tecnocrazia del Nord si identifica egemonicamente con l’intera nazione, ed elabora quindi un nuovo tipo di cultura e di lingua effettivamente nazionali.
Non essendo io un politico o un sociologo, non oserei circostanziare queste affermazioni, se non per apportarvi qualche litote: per assicurare, insomma, come non siamo che al primo momento di questo fenomeno, e che involuzioni, regressi, resistenze, sopravvivenze dell’antico mondo italiano saranno realtà ritardate ma sempre rilevanti della nostra storia ecc., che la ferita fascista continuerà a sanguinare ecc.: ma che tuttavia la realtà, ormai fatta coscienza e quindi irreversibile, è l’instaurazione di un potere in quanto evoluzione della classe capitalistica (non c’è stata nessuna calata di barbari!) verso una posizione realmente egemonica e quindi unitaria.
Perciò, in qualche modo, con qualche titubanza, e non senza emozione, mi sento autorizzato ad annunciare, che è nato l’italiano come lingua nazionale.
Che cosa sia o meglio cosa sarà questo italiano, non è facile definire: non si stenterà a crederlo. A questo punto, a questa definizione, dovrebbe cessare il mio contributo di facitore di libri e non di linguista. Ma non vorrei cedere il campo senza aver prima fornito qualche dato circostanziale e aver anticipato alcuni motivi di previsione.
In campo linguistico-letterario si aveva avuto in questi due ultimi decenni un apparente prevalere dell’asse Roma-Firenze (con qualche accentuazione su Roma, o magari su Napoli): tanto che si era parlato in sede glottologica di Roma come centro finalmente irradiatore di lingua, capitale di uno Stato finalmente unitario, sede della burocrazia ecc. ecc. Insomma la circolazione profondamente verticale e ampiamente orizzontale della lingua, pareva aver trovato in Roma il suo centro. La civiltà neorealistica aveva avuto come lingua l’italo-romanesco, e su tale base, assolutamente prevedibile e rassicurante, vorrei dire tradizionale, si pensava che si sarebbe avviata la nazionalizzazione dell’italiano.
Le cose sono invece, come s’è visto, di colpo cambiate: la cultura romanesco-napoletana si è rivelata improvvisamente e definitivamente diacronica – e, dopo la mora di purismo cui ho accennato – avanzano ora prepotentemente la loro candidatura a centri irradiatori di cultura e di lingua nazionale le città del Nord, l’asse Torino-Milano.
Ora, il Nord non può certamente proporre come alternativa i propri dialetti – che esso stesso ha contribuito a rendere arcaici né più né meno che quelli del Sud – né la sua pronuncia, né i suoi particolarismi linguistici: insomma la sua dialettizzazione della koinè. Ma è il Nord industriale che possiede quel patrimonio linguistico che tende a sostituire i dialetti, ossia quei linguaggi tecnici che abbiamo visto omologare e strumentalizzare l’italiano come nuovo spirito unitario e nazionale. Il Nord possiede tale linguaggio tecnologico in quanto mezzo linguistico principe del suo nuovo tipico modo di vita: è questo sottolinguaggio tecnico che il Nord industriale propone, come concorrente al predominio nazionale, contro la koinè dialettale romanesco-napoletana: e che, in effetti, è già vittoriosa, attraverso quella stessa influenza egemonica unificatrice che hanno avuto per esempio le monarchie aristocratiche nella formazione delle grandi lingue europee.
È la rivincita dei periferici, insomma: è la vittoria dell’Italia reale su quella retorica: una prima ondata periferica romanesco-napoletana corrispondente al primo momento reale dell’Italia antifascista ma ancora semisviluppata e paleoborghese, e ora una seconda definitiva ondata settentrionale, corrispondente alla definitiva realtà italiana, quella che si può predicare all’Italia dell’imminente futuro.
Quali saranno le caratteristiche più importanti di tale italiano nazionale? Essendo i linguaggi tecnologici per formazione internazionali e per tendenza strettamente funzionali, essi apporteranno presumibilmente all’italiano alcune abitudini tipiche delle lingue romanze più progredite, con una forte accentuazione dello spirito comunicativo, pressappoco secondo queste tre tendenze:
1) Una certa propensione alla sequenza progressiva, il che comporterà una maggiore fissità nei diagrammi delle frasi italiane, la caduta di molte allocuzioni concorrenti, col prevalere di una allocuzione che per caso o per ragioni di uso sia più cara ai più autorizzati utenti di linguaggi tecnici, ossia in prevalenza ai torinesi e ai milanesi. (È noto per esempio che i torinesi hanno sempre appreso l’italiano come una lingua straniera, ed hanno già un’abitudine all’apprendimento normativo, che si accentuerà nello spirito funzionale della tecnica, fino al livellamento di tutto l’italiano alla precisione inespressiva della comunicazione tecnica.) Tutto sommato si tratterà di un impoverimento di quell’italiano che era finora così prodigo della propria ricchezza in quanto disponibilità di forme, tanto da rendere la testa di ognuno di noi un mercato di forme linguistiche concorrenti.
2) La cessazione dell’osmosi col latino, che in tutti i salti diacronici nell’evoluzione così particolare dell’italiano, si è sempre conservata – quale caratteristica di lingua letteraria di élite – diventando più fitta e fertile proprio nei momenti maggiormente rivoluzionari (per esempio l’umanesimo, o il neo-classicismo ecc.).
3) Il prevalere del fine comunicativo sul fine espressivo, come in ogni lingua di alta civilizzazione e di pochi livelli culturali, insomma omogeneizzata intorno a un centro culturale irradiatore insieme di potere e di lingua. La conservazione dei vari strati diacronici lungo la storia, ripeto, ossia la ricchezza di forme dell’italiano, era dovuta semplicemente al fatto che l’italiano era una lingua letteraria, e quindi, da una parte conservatrice, dall’altra espressiva. Ora alla guida della lingua non sarà più la letteratura, ma la tecnica. E quindi il fine della lingua rientrerà nel ciclo produzione-consumo, imprimendo all’italiano quella spinta rivoluzionaria che sarà appunto il prevalere del fine comunicativo su quello espressivo.
Prima di congedarmi, un ultimo sguardo a quel quadro letterario la cui condizione di disgregazione e di caos è stata il pretesto di queste osservazioni. Ora è chiaro che tale caos corrisponde a un momento ideale di vuoto della storia: è finito un tipo di società italiana e ne è cominciato un altro. In questa mora, la confusione della letteratura, privata di riferimenti e di prospettive: e, in questa mora, la sostanziale liceità delle avanguardie, la cui azione sovvertitrice di lingua è tuttavia condotta contro una lingua che non esiste più, e la cui idea di una lingua futura consiste in una mitizzazione tecnologica che non ha nulla a che fare col reale apporto della tecnologia alla lingua. È chiaro che dopo la presa di coscienza della reale rivoluzione linguistica dell’italiano, la funzione delle avanguardie è terminata. E solo attraverso un approfondimento di tale coscienza, uno scrittore potrà trovare la sua funzione, postulare un «rinnovamento del mandato».
Anzitutto egli potrà impostare nei giusti termini la predizione, apocalittica, che nel futuro non ci sarà più richiesta di poesia, se, presumibilmente, nel futuro, ci sarà soltanto una radicalizzazione della lotta, tipica del resto di ogni lingua, tra comunicatività ed espressività. In tal senso lo scrittore italiano è favorito dall’urgere dei problemi linguistici che per lui sono una rivoluzione – mentre in Francia, in Inghilterra ecc. non sono che un’evoluzione, essendo il francese e l’inglese ormai da secoli lingue nazionali nel senso integrale del termine. E una evoluzione linguistica, per quel che riguarda la reazione dei letterati, è molto più insidiosa di una rivoluzione. Per un letterato francese o inglese o tedesco o russo la questione si pone in una concorrenza della tecnologia e della scienza (e dell’industria culturale), in una meccanizzazione fatale delle reazioni dei destinatari dei suoi prodotti ecc. ecc. Per un letterato italiano invece la questione si pone in modo più radicale: l’imparare l’abc di una lingua, con tutto ciò che questo implica: prima di tutto il non temere la concorrenza del linguaggio tecnologico, ma l’impararlo, l’appropriarsene, il diventare «scienziato» (per es.: non lavorare più, secondo i termini del vecchio mandato, su «prospettive» – ossia sul passato collocato nel futuro – ma su «ipotesi», che non presuppongono che altre ipotesi, senza illusori fini palingenetici dell’uomo ecc. ecc.).
In seno a questa nuova realtà linguistica, il fine della lotta del letterato sarà l’espressività linguistica, che viene radicalmente a coincidere con la libertà dell’uomo rispetto alla sua meccanizzazione. E non sarà la sua una lotta arida e velleitaria, se egli possiederà come proprio problema la lingua del nuovo tipo di civiltà. Come appropriarsi di questa lingua? Per un letterato borghese, d’ideologia borghese, la prospettiva è quella di essere prima o poi soppresso dalla lingua partorita da quello stesso potere a cui egli non si oppone e contro cui non combatte: quindi ha ben ragione di levare la sua querelle sulla propria condanna all’incomprensione, cioè alla sua morte preceduta da una lunga agonia formalistica. Per un letterato non ideologicamente borghese si tratta di ricordare ancora una volta, con Gramsci, che se la nuova realtà italiana produce una nuova lingua, l’italiano nazionale, l’unico modo per impossessarsene e farlo proprio, è conoscere con assoluta chiarezza e coraggio qual è e cos’è quella realtà nazionale che lo produce. Mai come oggi il problema della poesia è un problema culturale, e mai come oggi la letteratura ha richiesto un modo di conoscenza scientifico e razionale, cioè politico.
Pier Paolo Pasolini
(1964)

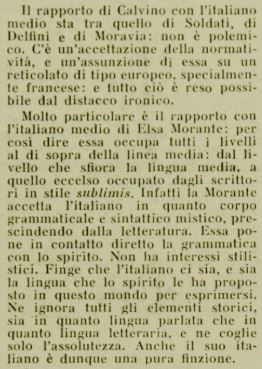

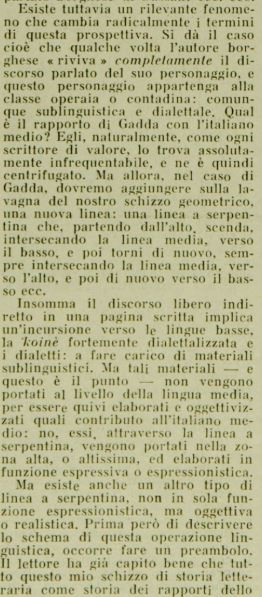


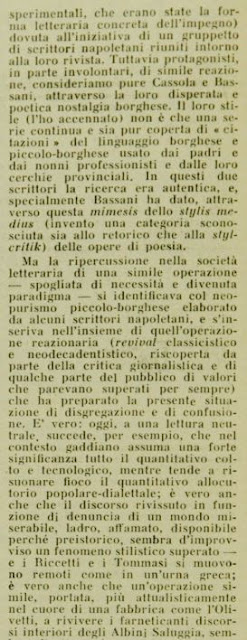








Nessun commento:
Posta un commento